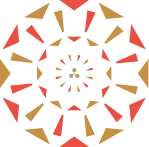Don Giorgio Ronzoni:
«Io sono fermo, ma è la Parola di Dio a correre»
La testimonianza del sacerdote rimasto completamente paralizzato dopo un incidente stradale, eppure ancora parroco grazie all’intervento e all’aiuto dei parrocchiani.

Don Giorgio Ronzoni
Uno pneumatico scoppia mentre l’automobile corre veloce, in un giorno di agosto del 2011. E la vita cambia per sempre. C’è un prima e un dopo, in questa vicenda di speranza e di tenacia. Prima: un sacerdote di 50 anni, parroco da tre, dopo tredici alla direzione dell’Ufficio catechistico diocesano. Dopo: una persona paralizzata dalla testa in giù. Può un uomo in queste condizioni continuare a essere parroco? Sì, se si chiama Giorgio Ronzoni. E se i suoi parrocchiani decidono che tutti insieme possono essere le braccia e le gambe del loro pastore. Siamo a Santa Sofia, la chiesa più antica di Padova, un gioiello romanico in fondo a una stretta strada porticata del centro storico. Don Giorgio non ama parlare di sé, ma accetta l’intervista e solo alla fine spiegherà perché.
Don Giorgio, dopo l’incidente cosa pensava del suo futuro?
Pensavo che non avrei più potuto fare il parroco. Nei primi mesi non muovevo nulla. Dopo 13 mesi di riabilitazione ho recuperato qualche movimento del braccio sinistro. Per incoraggiarmi monsignor Giuseppe Benvegnù Pasini (padovano, direttore della Caritas italiana dal 1986 al 1996, scomparso nel 2015, ndr) mi scrisse un biglietto in cui citava la risposta di un vescovo francese rimasto paralizzato a un dubbioso papa Ratti: «Pensavo che una diocesi si governasse con la testa, non con i piedi…». Ma sono stati i miei parrocchiani a chiedere all’allora Vescovo Mattiazzo di farmi restare. E lui disse sì.
Oltre ad amministrare la sua parrocchia, lei insegna alla Facoltà teologica del Triveneto. Come riesce?
La tecnologia aiuta: uso il computer, il telefonino e i tablet. I social no, non sono nelle mie corde. Ho due badanti che mi assistono 24 ore su 24. I parrocchiani hanno creato un’associazione, gli Amici di don Giorgio, e sono sempre presenti. Le esigenze pratiche si risolvono: c’è un ascensore che mi porta dalla casa alla chiesa, sono stati posizionati scivoli. Gli amici mi hanno regalato un’automobile con una rampa dalla quale posso salire con la mia carrozzina. Per la Messa, a turno due ministri straordinari girano le pagine del messale, mi mettono in mano patena e calice e distribuiscono l’Eucaristia.
Si è mai sentito isolato in quanto disabile? Be’, non è facile esserlo. Ma la mia esperienza è che ci sono ragazzi normodotati che sono molto più isolati di tanti disabili. Ci sono barriere visibili e invisibili e non è detto che esse siano appannaggio dei disabili.
Ha mai pensato “perché proprio a me”?
No. Anzi, mi sono detto: perché non a me? Non sono il centro dell’universo e trovo che “perché proprio a me?” sia una domanda stupida, con rispetto per chi se la pone. Perché dovrei essere proprio io a non patire lutti, malattie, difficoltà, incidenti? Tutti prima o poi conosciamo dolori e delusioni, non si può restare indenni dai problemi. Questo non vuol dire che io abbia accettato le conseguenze dell’incidente con il sorriso. Perdere l’autonomia è un colpo durissimo, abituarsi all’idea che non potrai fare più niente da solo, nemmeno le funzioni più intime, richiede tempo.
Nemmeno nei primi momenti si è sentito tradito da Dio?
Nello smarrimento ho avuto davanti a me due testimonianze: quelle del cardinale Martini e di san Giovanni Paolo II. Entrambi hanno vissuto la malattia con grande dignità. E poi ho riflettuto a lungo sull’ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli, quando Paolo era agli arresti e diceva: la Parola di Dio non è incatenata. Ecco io mi sento un po’ agli arresti domiciliari, ma come Paolo posso incontrare altre persone. La Parola di Dio continua a correre, la mia missione prosegue. E penso anche all’ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice a Pietro: quando sarai vecchio, un altro ti porterà dove non vuoi. La vecchiaia mi si è presentata a 50 anni. Quanto al sentirsi tradito da Dio, be’, sono sempre stato convinto che la fede non sia un talismano, per cui se righi dritto e sei un bravo ragazzo allora non ti succede niente. A san Paolo e a tutti gli altri qualcosa è capitato…

La sua fede che ruolo ha avuto?
Ognuno vive la fede a modo suo. Ci sono persone che soffrono molto e offrono le loro sofferenze. Io non vivo questa sensibilità. Mi riesce difficile pensare che ci sia bisogno di un tributo di dolore. Ognuno è chiamato ad offrirsi per se stesso, così com’è, completamente. Da quando sono in carrozzina ci sono più carrozzine in chiesa, probabilmente per qualcuno sono stato uno stimolo, un incoraggiamento. Qualcuno me lo dice: “Quando sto male penso a lei e mi faccio coraggio”. Va bene così, se aiuta qualcuno…
Lei non ama parlare di sé, però per Avvenire l’ha fatto. Perché?
Accetto di parlare di me solo per dire agli altri che ci sono tante altre possibilità. Chi sta attraversando un periodo difficile per una malattia, un lutto, un dolore, spesso aspetta solo che qualcuno gli dica: guarda che non è finita. Siamo abituati a valutare tutto quello che abbiamo perso, senza considerare quello che possiamo ancora fare. Credo che il mondo dell’handicap possa dare parecchio a questi tempi così narcisistici, in cui ogni desiderio viene scambiato per un diritto, in cui si pensa che la vita debba essere vissuta solo se si hanno tutte le possibilità. Non mi piace quando qualcuno, malato, sostiene di volersi togliere la vita “perché non posso più vivere in modo dignitoso”. È una mistificazione. Il sostantivo dignità ha due aggettivi: degno e dignitoso. È vero che molte persone nelle mie condizioni non vivono in modo dignitoso perché non hanno un’assistenza e un sostegno adeguati. Ma questo non vuol dire che la vita non sia degna. La vita è comunque degna, nessuno può toglierle la sua dignità.
Tra tutte le immagini di Gesù qual è quella che le piace di più?
Il volto della Sindone. Un volto che nella sua immobilità trasmette moltissima energia.
(Antonella Mariani, in “Avvenire”, martedì 13 novembre 2018)