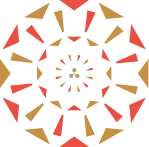ASSEMBLEA DIOCESANA PER TUTTI I CONSACRATI
A MORBEGNO
PRESSO LA SALA IPOGEA DELLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE
SABATO 5 APRILE 2025
dalle 9.00 alle 13.00
con la presenza di Suor Francesca Balocco
e di don Saverio Xeres
Carissimi Fratelli e Sorelle Consacrati/e,
con la presente rinnovo l’invito a partecipare alla Assemblea diocesana della Vita Consacrata, che si terrà nella mattinata di sabato 5 aprile, a Morbegno, presso la Sala Ipogea (via 5° Alpini, 190).
L’Assemblea è anzitutto un’occasione preziosa d’incontro per rinnovare la nostra comunione fraterna riflettendo e confrontandoci sulla nostra identità di Consacrati, ma è anche il modo col quale ci poniamo in stile sinodale all’interno della Chiesa di Como, consapevoli che la nostra vocazione trova senso e forza nella condivisione di un cammino ecclesiale.
In questo spirito, sarà con noi anche il nostro Vescovo Cardinale Oscar Cantoni, che condividerà la mattinata di riflessione e confronto.
In sintonia con il cammino giubilare, che la Chiesa sta compiendo in questo anno, nell’Assemblea ci interrogheremo su come la Vita Consacrata possa vivere in sé stessa ed essere per il mondo un segno di speranza, rispondendo alle sfide del nostro tempo con la luce del Vangelo e la gioia della nostra chiamata.
Ecco il programma della mattinata:
ore 9.00: accoglienza
ore 9.15: preghiera iniziale e introduzione del Vescovo
ore 9.30: sr Francesca Balocco, biblista – “La Speranza nella Vita Consacrata“
ore 10,15: risonanze in Assemblea
ore 10.30-11: pausa caffè
ore 11.00-11.45: don Saverio Xeres, docente di Storia della Chiesa – “Consacrati/e segni di speranza nel tempo“
ore 12.00: risonanze in Assemblea
ore 12.30: pranzo
Per chi desidera condividere il momento del pranzo, è necessario prenotarsi entro il 3 aprile scrivendo all’indirizzo email segreteriaoratorio.morbegno@gmail.com o al n di cell 339 4149177.
Nell’attesa di incontrarci, auguro a tutti un fruttuoso cammino quaresimale.
Don Marco Grega
Vicario episcopale per la Vita Consacrata
Nuova Olonio, 10.03.2025
…alcune foto dell’Assemblea per rivivere alcuni momenti di questo significativo incontro della Vita Consacrata in Diocesi









TRACCIA DELLA RELAZIONE
DI DON SAVERIO XERES
I religiosi segni di speranza nella storia della Chiesa
In apertura
Un breve testo ispiratore sul senso di questa carrellata storica.
Carlo Maria Martini, La Madonna del Sabato santo (anno 2000-2001).
«Maria sa coniugare il passato delle meraviglie del Signore col futuro che lui solo sa suscitare […] Il suo cantico di lode esprime al passato («Ha spiegato la potenza del suo braccio») le sue certezze per il futuro. La Madonna del Sabato santo ci insegna a ricuperare la memoria non solo come elemento di tradizione, bensì anche, e fortemente, come stimolo al progresso. Dovremmo chiederci alla scuola della sua fede ricca di speranza: in che maniera valorizzare, aggiornandole al presente, le grandi tradizioni del passato della Chiesa?».
I – Importanza fondamentale della vita religiosa per la Chiesa nella storia
-
In quanto tali, per la Chiesa in quanto tale
«Segno che può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana» (LG, 44).
Richiamo essenziale al senso proprio della Chiesa di Cristo, in fedeltà alle origini e in prospettiva del compimento.
-
Un dinamismo incessante nella storia
– continuo slancio (e rilancio) di configurazione a Cristo, mai adeguatamente realizzata.
– quattro fasi principali (configurazione giuridica):
* monachesimo antico (III-XII)
* mendicanti (XII-XVI)
* chierici regolari (XVI-XVIII)
* congregazioni e istituti secolari (XIX-XX sec.)
II – La fase del monachesimo antico
-
Origini (sec. III-IV – Antonio)
Al di là delle “somiglianze” con spiritualità diverse del mondo antico… l’intenzione di fondo è l’esigente sequela di Cristo.
– dalla persecuzione (e fuga nel deserto);
– dalla decadenza di una Xsa, non “libera” ma “protetta”, anzi asservita al potere politico
(“Impero cristiano (!): Costantino + Teodosio, sec. IV)…
… ritorno all’originaria marginalità (e “secolarità”, ossia alla “distinzione” tra le due sfere).
è Contributo fondamentale per dis-ancorare la Xsa da prospettive prevalentemente «del mondo» (cfr Gv 17, 16).
-
La tradizione “agostiniana”
(Agostino + Ambrogio, Eusebio di Vercelli; Gregorio Magno, Martino di Tours…; + grandi vescovi orientali: vita “monastica” come “strumento” di formazione del “secolare” (in continuità con i grandi vescovi orientali).
↓
Una lunga tradizione con vari sviluppi.
-
Il monachesimo in Europa
-
a) Benedettino (dal VI sec. Benedetto da Norcia)
– Apporto essenziale per la Chiesa = una “riserva” di uomini e donne forgiati da vita comunitaria, preghiera (ora), fatica (labora) studio (studeas).
→ Energie fresche pronte per la riforma della Chiesa nella successiva decadenza (secc. IX-X: anche per supplenza all’Impero fatiscente).
→ Risorse umane per la missione ai popoli germanici.
– Apporto essenziale per la società.
Le abbazie benedettine come “cellule” di vita, capaci di ricreare il tessuto umano, sociale, economico di un territorio e di una popolazione:
← Autonomia (tutto il necessario al proprio interno);
← Stabilitas (continuità nella trasmissione dei “saperi” e delle “esperienze”)
-
b) Monachesimo anglo-irlandese
– “Ri-cristianizzazione” degli Angli in Gran Bretagna (Gregorio Magno e Agostino di Canterbury).
↓
La nuova chiesa angla evangelizza le popolazioni del Nord dell’Isola (es. Scozia) e intreccia l’azione dei monaci d’Irlanda (Chiesa dal V sec. con Patrizio, proveniente dalla Gran Bretagna).
– Spiritualità irlandese: il viaggio, senza sicurezze come pratica “penitenziale”
(amor peregrinationis; xeniteìa)
– Sul continente europeo:
– diffusione della penitenza “privata”;
– diffusione della grande cultura (letteraria, geografica; patristica e biblica) dei monasteri angli e irlandesi (es. Alcuino di Yorke la Biblia palatina)
– Missione: Bonifacio (metà VII – metà VIII), dall’Anglia settentrionale, evangelizza le popolazioni dell’attuale Germania.
*con nuovi monasteri, anche femminili (es. abbadessa Tetta; biblista Lioba)
è Da una Chiesa nata da duplice missione (monastica: Gregorio M. + Irlandesi)…
una nuova missione per dare vita a nuove Chiese sul continente.
III – La fase mendicante
-
Grandi cambiamenti sociali
-
a) Fine dei “movimenti” di popoli sul continente
→ Consistente sviluppo demografico
→ Dalla prevalente “economia chiusa” alla prevalente “economia di scambio”
*** Intuibile crisi dei monasteri, legati a quell’impostazione socio-economica.
-
b) (Ri)nascita delle città
→ Nuova “classe” sociale urbana (artigiani / commercianti):
* intraprendenza
* individualismo
-
Nuovo clima spirituale
-
a) Appropriazione personale della religiosità
-
b) Desiderio di riforma (ritorno alla Ecclesiae primitivae forma)
↓
Vasti e diffusi movimenti di ritorno al Vangelo (Valdesi, Catari, ecc.) in polemica con la Chiesa “carnale” (ricca e potente).
-
Nuove aggregazioni di vita religiosa: i Mendicanti
-
a) Predicatori (o “domenicani”)
– Domenico di Guzman, prete, con altri preti: predicare la Verità ma nella povertà.
– Inserimento (anche) nelle città universitarie (Bologna, Parigi).
-
b) Minori (o “francescani”)
– Francesco: soprattutto l’”imitazione” di Cristo
→ né chierico né “monaco” (!)….
… ma “penitente” (=impegno battesimale)
… e “vero” religioso
– Incomprensione e “fallimento”: da “movimento evangelico” a istituzione giuridica
(“Ordine” religioso).
= somiglianza a Cristo.
-
c) Definizione della nuova tipologia di vita religiosa
Concilio di Lione II (1274), cost. 23
«Le loro [dei “Mendicanti”] Regole o Costituzioni impediscono di avere redditi e possedimenti per il necessario sostentamento, ma stabilisce che il vitto sia affidato all’incertezza del mendicare per mezzo della questua pubblica».
-
Il contributo dei Mendicanti
-
a) Il richiamo al Vangelo.
-
b) L’impegno pastorale attivo:
– dal monastero quale punto di riferimento verso il quale si orientano le popolazioni delle campagne, al convento come punto di “ricovero” dei frati normalmente tra la gente.
– sulle strade di accesso alla città, luoghi di passaggio e di marginalità.
→ Presenza nel mondo, ma distacco dalla mentalità del mondo.
-
c) Nuova linea pastorale per nuova classe urbana.
– predicazione (chiese, piazze) e/o spiritualità alla portata di tutti (es. Terz’ordini);
– confraternite e devozioni popolari (Bambino / Crocifisso).
*** Alternativa (con qualche polemica) alle chiese parrocchiali.
-
d) Limite: necessità dell’Ordine sacro per la predicazione → clericalizzazione.
-
L’emergere della “questione femminile” nella vita religiosa
-
a) L’esperienza di Chiara
Dall’imitazione di Francesco alla “reclusione”.
*** Inapplicabile la formula mendicante e, soprattutto, la predicazione itinerante alle donne, si perviene a una caratterizzazione di “secondi ordini” (femminili), con soggezione ai primi ordini (maschili) o ai vescovi.
-
b) La (parziale) “soluzione” di San Damiano
– “Recluse” ma in un luogo marginale e di passaggio (possibile luogo di ospitalità per poveri e pellegrini)
– Collaborazione (iniziale) con i frati.
-
c) La tenacia di Chiara
Il problema della “Regola” (già troppe esistenti) e «la prima regola per donne scritta da una donna».
*** La tenacia tipica della speranza e… del genio femminile.
*** Una questione che continuerà per secoli.
IV – La fase dei chierici regolari (secc. XV-XVII)
-
Il generoso contributo della vita religiosa nella più grave decadenza della storia della Chiesa
-
a) L’emergenza pastorale
Soprattutto per assenza e/o inadeguatezza del clero.
-
b) Religiosi in prima linea
– riformando se stessi (sia monaci che mendicanti)
– riproponendo l’unione vita religiosa + ministero ordinato (nuova configurazione giuridica)
Es. teatini, gesuiti, somaschi, camilliani…
** Limite: diventa “stabile” la qualifica “clericale” non originaria per i religiosi.
** Limite: donne nuovamente “escluse”
(attive nella riforma degli stessi Ordini maschili: es. Teresa d’Avila).
è Comunque: vera e propria “ri-animazione” del tessuto ecclesiale
(in parallelo con la decadenza!).
– formazione (del clero e dei laici);
– predicazione (missioni ad intra);
– sensibilità per alcune (nuove) povertà:
* ragazzi “sbandati” e/o orfani (es. Girolamo Miani)
* malati, soprattutto gli “incurabili” (Caterina da Genova, Camillo de Lellis, ma anche Ignazio di Loyola, Filippo Neri e altri)
-
c) Novità
– Collegamento con iniziative laicali (spontanee, numerosissime);
-
“Compagnia del divino amore” (Caterina da Genova)
– Collegamento con il clero secolare:
-
Filippo Neri: “Congregazione dell’oratorio”: “unione fraterna” di chierici e laici (o “società apostolica”), senza voti.
-
Barnabiti (Milano):
– Antonio Maria Zaccaria e l’Oratorio dell’Eterna Sapienza a Milano (presso chiesa di S. Barnaba);
– tre famiglie religiose:
* Barnabiti (chierici regolari);
* Angeliche (dedite all’apostolato, inizialmente senza clausura);
* “Maritati di S. Paolo decollato” (laici sposati)
è La speranza si sostiene insieme.
-
La “questione femminile”
Proprio per l’apostolato: come conciliarlo con la vita religiosa?
Breve excursus sulla clausura femminile
-
a) L’imposizione della clausura
– Bonifacio VIII, 1298 (decretale Periculoso): clausura per «tutte e singole monache, presenti e future, di qualunque religione e ordine»): proibizione di uscire (per loro) e di entrare (per gli altri).
– Ripresa dal Concilio di Trento e interpretata in maniera rigida) da Pio V (1566): professione solenne per tutte le aggregazioni femminili
Congregazione femminile = professione solenne = clausura.
– Applicazione rigida e dettagliata di Carlo Borromeo (grate, catenacci, chiavistelli): diffusa in tutta Europa.
– Fino al 1855: Pio IX [Neminen latet] riconosce la possibilità anche dei soli voti semplici.
-
b) Ricerca di soluzioni alternative solo momentanee
-
Angeliche (già citate);
Orsoline di Angela Merici (1544):
in famiglia e senza distinzione d’abito; assistenza domiciliare ai malati; catechismo, ecc.
Visitandine (Francesco di Sales e Giovanna Francesca di Chantal)
→ Ricondotte alla clausura (1610)
-
c) Tentativi riusciti
– Vincenziane (Vincenzo de’ Paoli): semplice “confraternita”
– altre (poco note) iniziative spontanee, anche locali (“semireligiose”)
-
d) Una lunga, sofferta vicenda (secc. XVII-XIX)
– la prassi consolidata della clausura forzata come “istituzione sociale”
– la “reclusione” introdotta per custodire il valore della vita religiosa blocca la sua stessa molteplice ricchezza.
– Il seme gettato sboccerà in nuovi germogli solo nel Novecento.
V – La fase delle Congregazioni religiose (e degli Istituti secolari) (secc. XIX-XX)
-
Congregazioni
-
a) La fase successiva al tracollo della “cristianità”…
… esige una rinnovata presenza “apostolica”.
→ Dai grandi Ordini alla più snella formula delle congregazioni;
→ Al primo posto l’impegno apostolico, soprattutto in ambito sociale (educativo, caritativo).
→ Si risolve anche la plurisecolare questione femminile
(cfr grande fervore di nuove fondazioni, anche per la missione ad gentes).
-
Istituti secolari
In quanto storicamente in continuità con le vicende della vita religiosa:
– realizzazione dei tentativi incompiuti di inizio età moderna (es Orsoline, ecc.)
– capacità di adattamento alle mutazioni epocali.
= Dalla marginalità della Chiesa nella società a modalità “invisibili” ma misteriosamente efficaci (ideale evangelico del seme e del lievito nella pasta).
-
Il permanente (anzi crescente) valore della vita monastica (e della stessa clausura)
-
a) In prospettiva missionaria
– Teresa di Lisieux:
«Capii che l’amore solo fa agire le membra della Chiesa; che, se l’amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue… Capii che l’amore racchiude tutte le vocazioni, che l’amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi; in una parola, che è eterno» (Ms. B, 254).
è Primato della Grazia nella vita e nell’azione della Chiesa
– cfr Barth (anni’30): missione come actio Dei.
– cfr Pio XI, Costituzione apostolica Umbratilem (1824):
«Coloro i quali si dedicano con zelo assiduamente all’ufficio della preghiera e della penitenza, assai più di coloro che coltivano con il loro lavoro il campo del Signore, contribuiscono al progresso della Chiesa e alla salvezza del genere umano».
– cfr piccole (e modeste) comunità ma “a disposizione” di chi cerca.
*** Importanza anche per i religiosi (e non solo) anziani e/o ammalati; o per gli Istituti in via di invecchiamento e/o riduzione…
-
b) In campo ecumenico
– Es. Monastero di Chevetogne (Belgio, 1925).
** Il monachesimo è nato prima delle divisioni e si nutre di una spiritualità comune all’Oriente e all’Occidente.
– Anche dialogo interreligioso (← monachesimo come elemento comune).
-
c) In campo teologico
♦ Ripresa di contatto con le fonti del cristianesimo
– Bibbia e Padri
* Le Saulchoir (domenicani), in Belgio: scuola teologica (Chenu, Congar).
* Lyon-Fourvière (gesuiti): De Lubac, Danielou; la collana Sources chrétiennes
– Tradizione liturgica
* Prosper Guèranger (benedettino): abbazia di Solesmes.
* Pio Parsch (agostiniano) = apostolato liturgico popolare.
* i benedettini di Finalpia (Liguria): “Rivista liturgica” (1927-) + settimane liturgiche
* lazzaristi (o vincenziani [Vincenzo de’ Paoli]: “Ephemerides liturgicae” (1887)
↓
♦ Riscoperta della vita cristiana come vita nella Grazia
Es. Columba Marmion (benedettino), Cristo vita dell’anima (1918)
Es. A. Poulain (gesuita), Le grazie dell’orazione, Trattato di teologia mistica (1931)
↓
♦ Profondo ripensamento sulla Chiesa (ricuperandone la dimensione teologica).
Es. Y.M. Congar (domenicano)
è Ruolo “culturale”/spirituale fondamentale per la vita della Chiesa, tradizionale per i religiosi.
Riflessioni conclusive
-
Tema della speranza
Sempre presente, anche se non esplicitato.
← Speranza come adesione a Dio (roccia; àncora…);
← Speranza come vita nuova del cristiano (Spirito);
← Speranza come “custodia” e “trasmissione” nella Chiesa;
↓
Attuata anche nelle opere “sociali” che rifluiscono nella società.
-
Prospettiva per il presente/futuro